La verità resta ancora
La verità, fondamento indispensabile per la fiducia e la convivenza

Il professor José María Desantes affermava che la componente essenziale del messaggio informativo è la verità. Quando manca la verità, la parola viene privata del suo riferimento alla realtà. Questo appello alla coerenza della parola si ritrova nel linguaggio colloquiale quando, di fronte a una notizia che ci sembra in qualche modo sorprendente, ci rivolgiamo subito al nostro interlocutore chiedendogli “è vero?”, “davvero?” Questo movimento spontaneo verso la verità di ciò che abbiamo sentito o letto la dice lunga su ciò che ci aspettiamo dai messaggi informativi: ci aspettiamo che ci comunichino la verità. Proprio ciò che i sociologi chiamano capitale sociale – come elemento essenziale della convivenza – richiede fiducia, le cui componenti essenziali sono: dire la verità, mantenere le promesse ed essere solidali. Senza verità, senza riferimento alla realtà, ciò che rimane sono frecce offensive, parole ingiuriose, dichiarazioni diffamatorie, falsi giudizi e deterioramento del tessuto sociale.
Una società sostenibile, oltre a prendersi cura delle proprie aree verdi, ridurre i rumori fastidiosi, tutelare l’integrità e la vita dei propri cittadini; Richiede inoltre di promuovere un clima di fiducia e armonia tra i suoi membri per elaborare progetti di miglioramento comune. In caso contrario, se nessuno si fida di nessuno, si instaura una corrosiva cultura del sospetto, alimentata da false informazioni e opinioni vuote, che denigrano la buona reputazione delle persone. Questa cultura del sospetto esiste, ma la naturale tendenza umana a vivere nella verità ci porta a cercare di alzare lo sguardo per non abituarci alla pula delle menzogne e delle falsità. Cercare la verità, dire la verità non è cosa da poco. Questo è stato il grande lavoro svolto da Aleksandr Solženicyn e Václav Havel ai loro tempi: la verità ha abbattuto la cortina di ferro.
Può esserci un disprezzo per la verità nello spazio pubblico che porta a promuovere un atteggiamento di incredulità o indifferenza verso ciò che alcuni mass media ci mostrano (un “qualunque cosa”). Tuttavia, questo atteggiamento di indifferenza o di incredulità verso le notizie di pubblico dominio non cancella il desiderio di verità nel cittadino comune. Lo sperimenti a casa quando una persona cara ha tradito la sua fiducia o la sua parola: “Perché non me l’hai detto?”, “Perché mi hai mentito?” Qualcosa si rompe dentro di noi. Ma è anche vero che è proprio in quest’ambito delle relazioni interpersonali, domestiche e amichevoli che cerchiamo rifugio dalle accuse ingiuste.
Sono queste le vie attraverso cui viaggia la verità nel suo duplice aspetto di oggettività e sincerità. L’oggettività si concentra sui fatti, sono i mattoni a cui faceva riferimento Sherlock Holmes e con cui si costruiscono i muri. I fatti si misurano e si osservano dall’esterno: ho questi titoli accademici, abbiamo venduto così tante unità di auto in un mese. La sincerità, d’altro canto, ha una dinamica diversa; È la manifestazione del mondo interiore in cui il mittente afferma che la sua parola corrisponde a ciò che realmente sente, crede o pensa. Così, quando Giulietta dice a Romeo che lo ama, lui si fida dell’affermazione della sua amata. Lui si fida di ciò che dice, non esiste alcuna ecografia del cuore dell’amato che corrobori la sua affermazione. Noi semplicemente ci fidiamo. L’obiettività manca quando i fatti vengono falsificati. La sincerità viene distrutta dall’ipocrisia. Alla base di entrambe le virtù c’è la verità, e quindi è possibile anche sbagliarsi sinceramente, come quando Romeo dice che la prima volta che vide Giulietta fu in una certa data e poi gli viene detto che la data era un’altra.
La verità, nonostante i vari modi di negarla o indebolirla, come il relativismo, l’agnosticismo, il pragmatismo, lo storicismo e altri “ismi”, continua a sussistere. La verità ci rende liberi e costituisce uno dei beni più preziosi del patrimonio dell’anima.
Related

Sincretismo e relativizzazione della fede: la sfida del relativismo religioso in un mondo pluralista
Javier Ferrer García
11 Aprile, 2025
5 min

So come esercitare l’autorità sui miei figli?
José María Contreras
11 Aprile, 2025
2 min
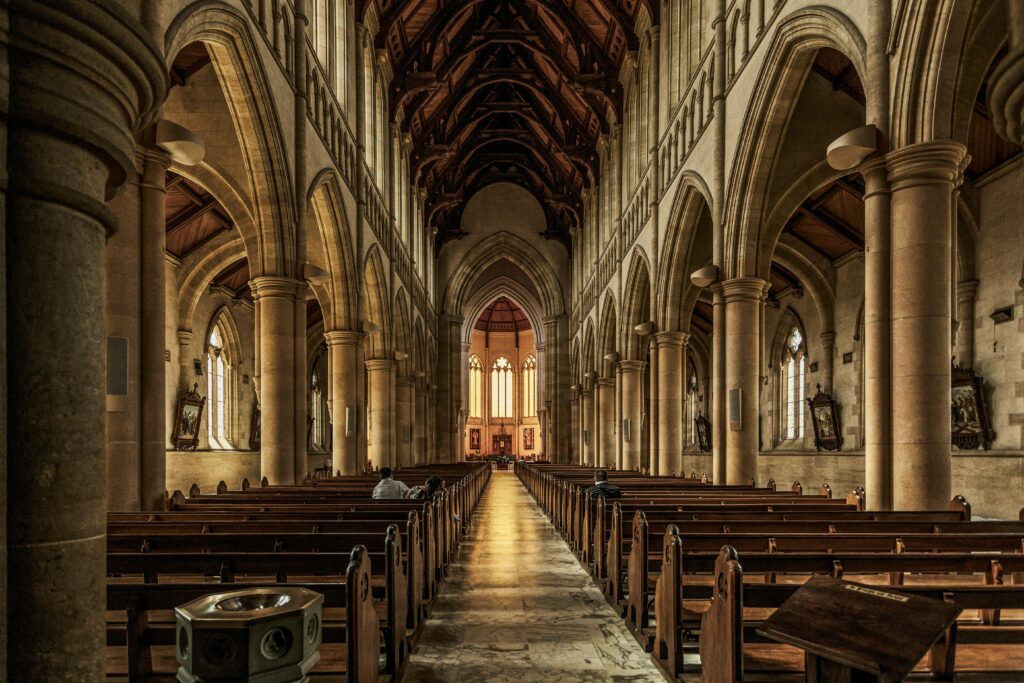
Distanziamento sociale in assemblea
Alfons Gea
11 Aprile, 2025
4 min

Il valore dell’umiltà al lavoro
José Miguel Ponce
10 Aprile, 2025
2 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

